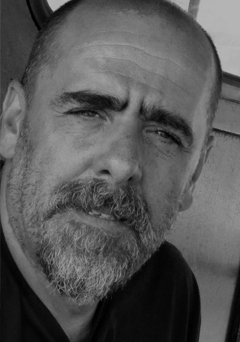Sartre sale su un taxi e Calvino gli fa fare un giro di onironautica – di Alan Poloni
(la letteratura in sette mosse assolutamente folli e illogiche)
Non sappiamo cosa sarebbe una cultura nella quale / non si sappia più che cosa significhi raccontare.
(Paul Ricoeur)
uno
Spesso dimentichiamo che quando parliamo di libri, di letteratura, di lettura, stiamo facendo riferimento ad un mondo la cui marginalità si fa ogni giorno più netta e triste e incurabile: fascette che ululano al capolavoro del secolo, apocalittici e integrati dinanzi al totem dell’ebook, beghe per premi letterari, appelli per salvare la letteratura… tutto questo rumore è, se non per nulla, per pochi, riguarda una piccolissima minoranza dell’umanità. In realtà il mondo va avanti anche senza libri, ed è lì a dimostrartelo in continuazione e con una certa supponenza. In fondo Flaubert già ci avvertiva che “tre cose occorrono per essere felici: essere imbecilli, essere egoisti e avere una buona salute. Ma se vi manca la prima tutto è finito”. Figuriamoci se uno deve star lì a leggersi l’Ulysse.
Il fatto è che la scritta la protezione norton è scaduta fa più effetto della fascetta dell’ultimo libro di Paolo Giordano. Eppure siamo qui a scriverne e a parlarne perché ci rimane il piccolo sospetto (sempre più piccolo) che la faccenda della protezione norton sia o dovrebbe essere milioni di volte meno importante dell’ultimo libro di Paolo Giordano*.
due
Sartre, per spiegare il ruolo del lettore all’interno del gioco narrativo, paragonava il testo letterario ad una trottola che esiste solo quando è in movimento. Voi pensate ad una trottola, pensatela immobile e spenta: ecco, in quel momento, dice Sartre, non esiste, nel senso che non è la vera trottola, la cara vera vecchia trottola che tutti conosciamo dai tempi in cui il bavaglino era un bene primario. La trottola diviene trottola solo nel momento in cui la mettiamo in movimento. Ora, il caro vecchio e un po’ strabico Sartre (troppe ore con le trottole, amico?) diceva che quando voi entrate in una libreria, una di quelle belle librerie dove migliaia di libri riposano ordinatamente, ebbene, se ci pensate bene, tra voi e quei libri può scattare la stessa faccenda della trottola: essi non sono ancora libri, non sono altro che un piccolo cimitero di lapidi, come li chiama Cavazzoni, sospesi in una sorta di sonno temporaneo provocato dal maleficio di chi li ha scritti: sarete voi il principe azzurro che ridarà loro vita a fior di labbra?
Questa concezione del libro vivo solo in virtù di un’attivazione esterna mi è sempre piaciuta, ho sempre trovato affascinante l’idea del libro come qualcosa di inerte finché qualcuno non lo aprisse e si mettesse a leggerlo. C’è stato un periodo (breve) in cui il mio trip era la “teoria della ricezione”, la risposta da parte di un gruppo di studiosi teutonici allo strapotere del formalismo russo: i tedeschi ribaltavano la centralità del testo (e dell’autore) e, richiamandosi alla fenomenologia e all’ermeneutica, mettevano in primo piano il momento della ricezione, mettevano in primo piano gli occhietti assorti del lettore e i mondi in costruzione in uno dei suoi emisferi.
Quando poi ho cominciato a scrivere, questa centralità del lettore ha iniziato a venirmi un po’ a noia: quelli della scuola di Costanza la menavano continuamente con la storia del lettore ideale, a pagina 33 de La teoria della ricezione arrivavano perfino a dire che “ogni opera letteraria contiene l’immagine del suo lettore” e “il lettore è, si potrebbe dire, un personaggio dell’opera”. Erano passati da una cosa che condividevo, la faccenda che soltanto la lettura attualizza l’opera, ad una vera e propria ingerenza, quella del lettore. Gli davi la mano, a questi di Costanza, e si prendevano la letteratura. Insomma, io, quando scrivevo non avevo in mente nessun lettore ideale e il lettore (ci mancava altro) non era un personaggio dell’opera!**
tre
E così mi sforzai infinitamente fino a sostituire la metafora della trottola con qualcosa che mi piacesse di più. Mi saltò fuori un taxi. Se con Sartre e la faccenda della trottola eravamo arrivati a mettere freno all’icarismo dall’autorità autoriale, con la teoria del taxi non so bene dove eravamo, probabilmente dalle parti in cui il lettore aveva la sua bella importanza ma l’autore continuava ad averne un pochetto di più, di fatto per una questione di centimetri; in entrambi i casi si tende a considerare la letteratura un gioco a due: da una parte c’è qualcuno che dice “è il lettore a fare la letteratura”, poco oltre, entriamo in un territorio delimitato dall’insegna borgesiana: “tu che mi leggi, sei sicuro di intendere la mia lingua?”
In questo mondo di taxi-letteratura c’è un lettore che stipula un contratto con l’autore: è la corsa, col suo bel punto di partenza e il suo bel punto di arrivo; il lettore sale sul taxi e indica all’autista dove vuole andare, ma il volante ce l’ha l’autore ed è lui a portare il mezzo. Trovo più che giusto che l’autore resti il vero padrone del gioco: la parte del lettore è limitata, forse perfino illusoria, in quanto gli spazi che l’autore gli concede sono davvero pochi e, probabilmente, già determinati. Il lettore dal canto suo può sempre decidere di interrompere la corsa.
quattro
Spesso l’autore è professionale: dice una cosa e poi, effettivamente, la fa. Dice al lettore: la porto a scoprire chi è il maledetto assassino di questa povera ragazza mutilata, e poi lo fa. Dice al lettore: la porto in un incredibile paesaggio distopico dove le pecore suonano il punk-rock, e lo fa. Ma talvolta l’autore è un cialtrone e non mantiene le promesse: magari fa fare un giro più lungo, o sceglie delle strade secondarie o fa delle deviazioni non previste, magari si perde oppure arriva prima di quanto avesse concordato***. Pensate a uno sciagurato libraio che consiglia Quer pasticciaccio ad un appassionato di noir: il lettore sale sul taxi e si frega le mani alla vista di tutto quel bailamme delittuoso, ma ad un certo punto, cioè prima di essere arrivati a destinazione, poco prima di giungere allo svelamento del mistero, si sente dire da Gadda “la corsa è finita, amico”****. Sì, perché è vero che il lettore paga, controlla, sbircia, e in qualunque momento può decidere di scendere, se la guida, il percorso, la compagnia del tassista non gli garbano, ma è altrettanto vero che pure l’autista del taxi-letteratura può mollarlo lì da un momento all’altro. Ecco, io quando scrivo sono uno di questi tassisti poco professionali. Mi piace allungare, deviare, perdermi via in storie inutili, risacche e appendici, scorci e panorami non preventivati. Mi piace Lukàcs*****, che in Teoria del romanzo scrive “opponendosi all’essere che riposa sulla forma finita, il romanzo appartiene dunque ad un altro ordine: al divenire, al processo”. Ibrido, meticcio, aperto, il romanzo non riposa su una forma finita, è una non forma, e ha sempre basato la propria forza proprio sul non averne.
cinque
Ho sempre sentito l’esigenza di trovare buone giustificazioni al fatto di leggere e scrivere storie. Forse avrei dovuto leggere le Città invisibili a nove anni, giusto per mettermi subito in circolo gli anticorpi. La diffidenza verso le storie è da addebitare alla ragione (la “sospensione dell’incredulità” di Coleridge vien sempre più difficile) in quanto artefice di quel pensiero scientifico che si è sostituito al mito. Troviamo tutte le risposte alle nostre domande su Focus e con la mappatura delle neuroscienze un giorno avremo il navigatore satellitare nel cervello. Presso il mondo adulto, un mondo che relega le storie all’età infantile (più o meno fino allo svelamento di Babbo Natale), l’unica possibilità di ridurre il caos a ordine è data dal discorso scientifico (e da quello politico, ahahahahah!). Il logos, innestato dalla cultura ellenica su un arbusto più che ricettivo come quello del principio di non contraddizione, ha camminato per quasi tre millenni col preciso obiettivo di cancellare l’indebita pretesa della narrazione di poter dare forma all’esperienza, di poter interpretare il reale attraverso la rappresentazione dello stesso, un sistema del tutto inaffidabile al confronto del prefetto meccanismo logico-matematico. Che poi il logos (la parola, il discorso…) era un modo che ancora lasciava spazio alle storie… Il problema è stato quando si è imposta la ratio (il numero… reddere rationem: fare i conti), quella cosa che dall’analogico ci ha portati dritti dritti all’alta definizione del digitale. Ecco: a me il romanzo piace proprio perché non è digitale, è una cosa imprecisa, che non sa che farsene dell’alta definizione; mi piace perché non fa i conti, perché non ha la pretesa di spiegare tutto, di mostrare tutto, di capire tutto******; ci permette di vedere cose che vanno oltre il tutto, perché ci dà spiegazioni assurde e implausibili, perché ci fa conoscere il commissario Ingravallo e Rastignac, perché ci fa ammazzare una vecchietta e risvegliare nell’uomo scarafaggio. Il romanzo è la libertà dell’imprecisione, e io continuo a desiderare di vivere in un mondo dove a piantare degli zecchini poi spunta un albero che fa gli zecchini. Nel nostro invece non si può, perché arriva subito la Finanza.
sei
Abbiamo così bisogno di storie che, perfino nel sonno, ce le raccontiamo. A proposito di sogni: sapete chi è un onironauta? L’ha studiato e coniato lo psichiatra Frederik Van Eeden: l’onironauta è il protagonista di un sogno lucido, cioè un sogno consapevole, un sogno caratterizzato dal rendersi conto che si sta sognando. L’onironauta è in grado di cercare nel sogno delle prove che gli confermino che sta sognando; le prove, detti test di realtà, sono cose come guardare l’orologio più volte (l’orario indicato cambia sempre), spegnere la luce (nel sogno non si riesce), respirare sottacqua, guardarsi allo specchio (guardandosi allo specchio nel corso di un sogno, si ha come esito un’immagine deformata, sostituita o persino assente: questo è indice che il soggetto non è in stato di veglia). L’onironauta, il sognatore lucido, è colui che può esplorare e addirittura, se è bravo, governare il proprio sogno. Il primo onironauta fu un marchese francese di un paio di secoli fa: aveva capito che il momento migliore per l’onironautica era quello del primo sonno, quello leggero e superficiale, e allora il nobiluomo si faceva svegliare in continuazione, anche venti volte a notte, e in questo modo governava i propri sogni. Un pazzo. Non si fa prima a leggere un libro?
sette
Il fatto di non potersi riconoscere nell’oniro-specchio mi sconvolge. Io voglio riconoscermi anche nei sogni! Scriveva Proust che “in realtà ogni lettore, quando legge, è soltanto il lettore di se stesso. L’opera dell’autore è soltanto una sorta di strumento ottico ch’esso offre al lettore per permettergli di scorgere ciò che forse, senza il libro, non avrebbe visto in se stesso.” Leggere se stessi è una cosa meravigliosa. Leggere ed essere letti.
Lo specchio, da Colombo agli omonimi neuroni, passando attraverso Borges e Lacan, racchiude qualcosa di ben più profondo e misterioso di una bella allegoria. Altrettanto profondo, forse sconfinato, è il mondo onirico. La letteratura è onironautica e, allo stesso tempo, speculazione (intesa come specchiarsi): il fatto di specchiarsi dentro una cosa scritta da un altro è una possibilità inestimabile per i nostri tempi schizoidi (brutta storia l’identità, eh?): avere la sensazione di capire qualcosa di noi attraverso vite altrui (per giunta inventate, e spesso di sana pianta!) ha davvero del miracoloso. La letteratura è onironautica: il fatto di entrare dentro un sogno che un altro governa per noi, e che lo governa così bene che ci specchiamo pure (e non dobbiamo essere svegliati venti volte a notte) non ha pari in nessuna avanzatissima tecnocosa…
Tra l’altro smettere di essere noi stessi GRATIS, senza rischiare sistema nervoso e fegato, è un’altra faccenda di un certo interesse, non è vero? Voi lo sapete che, mentre leggete Le città invisibili, voi assumete la voce, anzi no, voi siete ATTRAVERSATI per ore e ore dalla voce di Italo Calvino? Cioè, siete dei medium. Cioè, non c’è app che tenga, signori.
Ah. La corsa è finita. Potete scendere.*******
*E stiamo parlando di Paolo Giordano, mica di Julio Cortàzar…
**Ci aveva già provato Calvino, e il libro era un gioiello, ma quello restava un unicum.
***A proposito di Cortàzar: “Credo di irritare un po’ i miei compagni di passeggiate con le mie soste e sparizioni laterali in ogni istante”.
****Naturalmente un avveduto lettore di noir prenderà coscienza che il libraio gli ha rifilato un prodotto avariato nel momento stesso in cui si ritrova a leggere la descrizione di escrementi di gallina lunga una pagina.
*****Non siate banali. Il filosofo, intendo.
******Anche quando si propone di metterci dentro tutto, come nell’opera-mondo, chiaramente fallisce, e noi mica ci lasciamo prendere a codate da Moby Dick perché è un’opera mondo.
*******Se vi gira un po’ la testa, è la trottola…