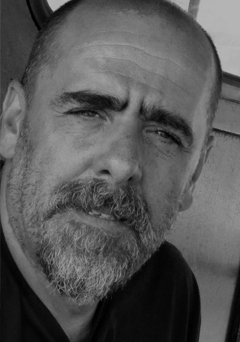Quando muoiono gli autori: leggete Cormac McCarthy – di Alex Piovan
Una delle storie d’amicizia, delle storie d’amore più belle che abbia letto racconta di un ragazzino e di una lupa. È una storia semplice: sono gli anni Quaranta, siamo in America, vicino al confine messicano; il ragazzino è un cowboy e la lupa sta divorando il bestiame della sua famiglia, perciò lui deve trovarla e ucciderla. Ma quando riesce a intrappolarla, anziché spararle, decide di riportarla a casa sua, in Messico. La prende, e vanno.
Ho scoperto Oltre il confine di Cormac McCarthy grazie a una puntata di Totem di Alessandro Baricco intercettata forse per caso su YouTube: ero un ragazzino anch’io, e quando comprai il libro non sapevo che stavo per leggere uno dei più grandi scrittori contemporanei, che stavo scoprendo uno degli autori che avrei amato di più e che più avrebbero plasmato la mia idea di letteratura. Non sapevo quante volte mi sarei commosso sulle sue pagine: per la forza, per la bellezza. Né che mi ci sarei anche rotto la testa, perché McCarthy non è solo il McCarthy della Trilogia della frontiera e della Strada: Suttree, per esempio, al primo colpo l’ho mollato – sarebbe diventato uno dei miei romanzi preferiti solo al secondo e al terzo giro, dopo avergli dedicato il tempo necessario e averci faticato sopra: serve pazienza, perché fare finta di no? Anche di Meridiano di sangue, che pure ho amato subito, so che mi sfugge ancora tanto, tantissimo. Dopotutto “books are made out of books”, ed è un bel guaio: perché i libri che abbiamo letto sono e saranno sempre meno di quelli che invece non abbiamo letto. Ma questo non dovrebbe frenarci, al contrario: non solo non finiremo mai i gettoni per giocare, ma visto che la partita è persa in partenza possiamo godercela senza l’ansia di vincere, azzardando strade oblique e fregandocene delle regole.
Quando comprai Oltre il confine non sapevo niente di tutto questo. Non avevo mai letto Faulkner, non avevo mai letto Moby Dick. Non avevo letto la Bibbia, e ancora oggi non l’ho fatto. Ma il grande merito di spettacoli come Totem e trasmissioni come Pickwick è che parlavano dei libri come di qualcosa di vicino, che in qualche modo ti riguarda e ha qualcosa da dirti anche se tu, di quella roba lì, non sai nulla. Ne parlavano come di qualcosa di cui è semplicemente figo parlare. Ecco: ho l’impressione che questo non piaccia, che il tentativo di dire che quella roba lì è per chiunque se ne incuriosisca sia visto un po’ come un tentativo di contaminarla, tirarla giù dalla torre e fuori dagli spazi giusti. Ho l’impressione che molti di quelli che sfottono i “libri pop” e chi li legge siano i primi a volere che gli altri leggano i “libri pop” per poterli sfottere e attribuirsi così una qualche patente di superiorità.
È piuttosto evidente anche quando muore un autore importante. Quello che succede è questo: l’autore importante muore, i giornali ne parlano, la tivù ne parla, gli utenti dei social ne parlano, ne parlano tutti, e un sacco di gente che non l’aveva mai sentito nominare vuole far parte di tutto questo, si incuriosisce, va in libreria, e in libreria trova tutti i libri dell’autore importante che è morto perché i librai sanno come funziona e hanno fatto un grosso rifornimento. Ed ecco che, puntualmente, qualcuno commenta: “Adesso che è morto lo leggete tutti”. L’implicito è che lui, a differenza vostra, lo conosceva e lo leggeva già quand’era vivo, e perciò è più bravo e migliore di voi. Senz’altro è capitato anche a me di dire qualcosa del genere, figurarsi: è anche una questione di gelosia, credo – è normale.
Ma se siamo convinti che quell’autore sia un gigante (e nel caso di McCarthy è così), che quelle siano le vette della letteratura (ed è così), che quei libri siano migliori di tanti altri libri più conosciuti e più letti (ed è così), non dovremmo essere felici che ci siano persone che ci si avvicinano? Che importa come, quando e perché succede? Temiamo che il libro finisca nelle mani di qualcuno che non è in grado di apprezzarne la grandezza? Okay, la caption di Instagram tirata via e scritta male tanto per timbrare il cartellino fa storcere il naso. Okay, la recensione acida e corriva che accompagna il giudizio a una stellina su Amazon magari è una recensione imbecille, e non tanto perché attacca l’inattaccabile (l’inattaccabile non esiste), ma perché manca di argomenti, di impegno, della serietà che ci vorrebbe. Ma le caption di Instagram e le recensioni su Amazon non sono niente, non rimangono, non scalfiscono in alcun modo un grande libro, una grande storia. Sicuramente fanno meno danno che maneggiare i grandi libri e le grandi storie come forbici appuntite da tenere lontano dalle mani dei bambini, come mondi esclusivi che richiedono una licenza per entrare, una selezione all’ingresso. Non è così.
Perciò, se oggi le librerie saranno piene di gente che comprerà i libri di Cormac McCarthy, io sarò contento. Perché McCarthy era uno dei più grandi. Uno che non ha barattato le storie con la presenza e la popolarità e il consenso e i soldi (la moglie ha raccontato che, quando avevano a stento i soldi per mangiare, gli proponevano di pagarlo per andare a parlare nelle università e lui si rifiutava perché “quello che ho da dire, lo scrivo”: alla fine hanno divorziato). Uno che sapeva che la letteratura non raddrizza alcunché, non indica la via ma te la fa perdere, non dà risposte ma pone le domande che avremmo paura di fare fuori da lì. Che la letteratura, per dirla con David Foster Wallace, “si occupa di cosa vuol dire essere un cazzo di essere umano”. Se vi viene voglia di leggere McCarthy solo perché da qualche parte avete sentito che è morto il più grande scrittore contemporaneo, leggetelo: l’unica cosa che conta sono i libri, il resto è brusio di fondo.