Lo straniero (storie di scrittori senza patria) – di Paolo Zardi
Quando nel 1955, un oscuro editore francese, il cui catalogo si componeva sostanzialmente di letteratura al confine tra l’erotismo e la pornografia (generi che distano tra loro quanto la tensione e la suspense), pubblicò il romanzo di un autore che aveva vissuto i primi vent’anni a San Pietroburgo senza scrivere nulla, i secondi vent’anni in Germania pubblicando libri in russo per gli esuli come lui, e gli ultimi sedici negli Stati Uniti d’America, scegliendo di esprimersi esclusivamente in lingua inglese, quell’autore, Vladimir Vladimirovic Nabokov, una volta che quel romanzo, Lolita, divenne un successo editoriale senza precedenti, e tutta la critica letteraria mondiale si accorse improvvisamente di lui, disse con la consueta spavalderia: “Meritavo che succedesse molto prima”. Anni dopo, David Foster Wallace, nella lunga intervista poi proposta in Come diventare se stessi (un libro mal riuscito, capace di ridurre involontariamente, e brutalmente, il mito di DFW), disse che Nabokov, mentre lo diceva, dimostrava di avere un atteggiamento da signorotto feudale – qualcuno convinto di occupare il posto in cima a una montagna fortificata.
Nabokov, che da ragazzino apparteneva a una famiglia ricca, colta e illustre, e che poi era caduto in uno stato di semi-povertà a causa della rivoluzione russa, aveva una grandissima stima di sé – stima che solo in parte stemperava con l’autoironia, come quando diceva, ad esempio, che lui pensava come un genio, scriveva come un autore eminente ma parlava come un bambino di cinque anni. Quando insegnava letteratura in un’Università americana, tra metà degli anni quaranta e i primi anni cinquanta, e raccontava la grandezza dei suoi autori preferiti – Puskin, Gogol, Dickens, Cechov, Flaubert, Proust, Kafka – è probabile che ritenesse di far parte di quel piccolo gruppetto di giganti, distaccando di tante lunghezze tutti quei romanzieri che gli erano contemporanei e che avevano raggiungo la fama in meno dei cinquantacinque anni che erano serviti a lui. Per dare un’idea della considerazione che aveva di sé: in un’intervista gli chiesero se nei suoi romanzi il tempo avesse qualcosa di proustiano; lui rispose che l’aggettivo giusto era nabokoviano. Riteneva di avere inventato, in letteratura, qualcosa che sarebbe stato ricordato. Ma anche se la sua aspirazione a occupare un ruolo fondamentale nella storia del romanzo aveva basi solide, e buoni motivi per essere alimentata, Nabokov aveva un limite che nessuno dei suoi sfidanti aveva: era troppo nabokoviano.
Nabokoviano può voler dire molto cose: bizantino, assurdo, fantasmagorico, elegante, farfallesco – ma l’aspetto più rilevante della sua produzione, e quello che forse dà un significato all’aggettivo, è l’amore sconfinato per la bellezza esteriore: per i dettagli, per il suono di ogni singola frase, per le metafore, per la struttura delle opere (con i suoi rimandi interni, le simmetrie, i trabocchetti). I suoi libri sono enormi trompe de l’oeil, dove tutto sembra vero, ma tutto è, allo stesso tempo, evidentemente falso: Nabokov non cercava mai il realismo, ma un gioco di prestigio che facesse esclamare per lo stupore e la meraviglia. La sua lingua è ricchissima di sfumature, di forme retoriche, di giochi di parole, di aggettivi, di neologismi – è una vertigine di continue invenzioni. Con il passare degli anni, però, Nabokov smise di esercitare una qualche forma di controllo su questa sua immensa capacità immaginifica, e finì per compiacersi della propria abilità: l’esempio più eclatante di come sia possibile gettare al vento il proprio talento è Ada, o ardore, che nelle intenzioni di Nabokov doveva essere un’opera all’altezza dell’Ulisse di James Joyce, e che invece mostra come l’insieme di 600 bellissime, presuntuosissime pagine non facciano necessariamente un romanzo.
In ogni caso, eccessi esclusi, si può dire che praticamente nessuno sia mai riuscito a raggiungere la perfezione della sua prosa. E poiché Nabokov ne era consapevole, ogni volta che qualcuno lo paragonava a Joseph Conrad, un altro scrittore di madrelingua slava che scriveva in inglese, sbottava dicendo che Conrad era un romanziere di serie B; e in effetti nessun autore poteva trovarsi così distante dalla sua nabokovianetà, (tranne, forse, Faulkner, che infatti disprezzava con lo stesso ardore).
Se Shakespeare fosse stato preso, e diviso in due parti, mettendo da un lato il giocoliere delle parole, il brillante commediografo, l’inesauribile creatore di metafore, l’abilissimo costruttore di trame, e dall’altro il tragediografo vigoroso del ciclo dei re inglesi, o quello di Antonio e Cleopatra, o Re Lear, con i suoi personaggi tormentati, la prosa poderosa, virile e asciutta, la visione pessimista della natura umana, la profondissima umanità, il dolore immenso, è probabile che Nabokov si sarebbe preso tutta la prima parte, e Conrad la seconda. Conrad può essere definito shakespeariano tanto quanto Nabokov, ma solo perché Shakespeare era tutto e il contrario di tutto: solo mettendoli insieme, avrebbero potuto fare un bardo intero.
Conrad è, a tutti gli effetti, uno scrittore che sta agli antipodi rispetto a Nabokov. La sua prosa, scolpita nella roccia, è nervosa, funzionale, a tratti faticosa – si intravede lo sforzo di una mente volenterosa, e volitiva, tutta tesa nell’attività di trasferire sulla carta un tumulto interiore, il risultato di una lunga, instancabile, laboriosa, ed estremamente faticosa, macinatura: di sassi. Nabokov danza sulle punte strizzando un occhio al pubblico e uno alla ballerina, Conrad spinge tronchi d’albero a mani nude e non guarda proprio nessuno. Ma se Nabokov disprezzava Conrad per la sua mancanza di stile, è probabile che Conrad si sarebbe risentito nell’essere paragonato a uno scrittore che era, se non immorale, quanto meno amorale: nessun personaggio di Conrad avrebbe mai potuto innamorarsi di una bambina di 12 anni (e, a dire il vero, nessun personaggio di Nabokov sarebbe mai stato capace di portare una nave in salvo da un tifone). Nabokov si prendeva gioco dei suoi personaggi e dei lettori (mai di se stesso), e rideva della follia; Conrad, anch’egli privo di autoironia, aveva invece un rispetto quasi religioso verso l’umanità intera, e gli errori e le manchevolezze degli esseri umani lo gettavano nello sgomento.
Eppure, nonostante la loro distanza incolmabile, e sebbene nessuno dei due avrebbe mai accettato un accostamento all’altro, Conrad e Nabokov hanno qualcosa in comune, e di profondo: entrambi possiedono lo sguardo di uno straniero, che è ciò che contraddistingue, e definisce per differenza con l’ottocento, il romanzo del novecento.
Non è da escludere che questa vicinanza derivi dalla somiglianza tra le loro vite – entrambi fuggono, più o meno volontariamente, dalla propria patria, entrambi si trovano a scrivere in una lingua che non è la loro (sebbene Nabokov dicesse che a casa sua si parlasse correntemente inglese), ed entrambi si trovano costretti a guardare il mondo in cui vivono da un punto di osservazione esterno. Ed è questa distanza che rende grandi Conrad e Nabokov: questo sguardo un po’ scientifico che prende nota di come gli animali chiamati homo sapiens si muovono, si amano, si combattono, perdono, muoiono e ancora si amano, senza riuscire a capire fino in fondo il linguaggio (non solo le parole: i gesti, le abitudini, la struttura sociale) che usano per farlo.
Nabokov osserva prima la Germania pre-nazista, poi l’America dei motel, della ricchezza, della sua natura sconfinata, ed è come se durante un pranzo organizzato nel nostro salotto, con amici e parenti, ci fosse qualcuno seduto sul divano, con il cappello sulle gambe, che non ride, non mangia, non scherza, ma guarda, un po’ imbarazzato, e non dice nulla, come farebbe uno zoologo che si piazza nelle vicinanze di un gruppo di scimpanzé, e cerca di individuare il senso di quella comunità – la gerarchia, il capobranco, i gesti. L’apice di questo approccio lo si trova in uno dei suoi libri meno famosi, ma tra i più belli ed equilibrati, Pnin, la storia di un professore russo trapiantato in America.
Conrad gira tutti gli oceani, sforzandosi di guardarli come li avrebbe guardati un inglese; ma quando, su richiesta di una compagnia commerciale belga, finisce nel cuore della foresta equatoriale, alla guida di una barchetta mezza scalcagnata, alla ricerca di Kurtz, è due volte straniero, perché non comprende l’Africa selvaggia che lo rifiuta e lo accoglie, e allo stesso tempo non capisce l’insieme dei valori europei (la devozione trascendente verso il lavoro, la missione civilizzatrice) che lo stanno spingendo, con una forza bruta, verso il cuore delle tenebre. È per questo che il suo libro più bello, quel Cuore di tenebra dal quale Coppola trarrà il capolavoro Apocalypse now, è costruito su continui ossimori: perché l’ossimoro è la condizione stessa dello straniero che vive nell’incapacità di risolvere un conflitto tra mondi diversi, e che lo vede involontario spettatore.
La partecipazione di Conrad e Nabokov è, per forza di cose, limitata, incompleta: in quanto stranieri, sono costretti a tradurre quello che vedono, e in questo sforzo di traduzione trattengono qualcosa – un residuo di significato, o tracce di meccanismi che tutti gli altri hanno smesso di notare. Non sono i soli, nel novecento, ad avere questo sguardo un po’ alienato: a Praga troviamo Kafka, tedesco in Boemia, ebreo tra i tedeschi; e proprio da Praga Kundera fugge verso Parigi, da dove ricostruirà il suo mondo perduto. Proust si esilia nel suo appartamento di Boulevard Haussmann 102, per guardare la vita da lontano. Albert Camus (anch’esso accostato a Nabokov, e da Nabokov disprezzato) nasce in Algeria, ed è francese; quanto torna a vivere in Francia, si sente uno straniero (e infatti scrive il suo libro famoso, che è, appunto, Lo straniero). Oltre oceano, qualche decennio dopo, troviamo Philip Roth, un americano che racconta il mondo delle comunità ebraiche, e un ebreo che guarda l’America con disincanto; e, poco prima, Nathanael West, un intellettuale prestato al Cinema, che racconta Hollywood come se lui fosse un extraterrestre atterrato per errore in California. I loro seguaci – Amis tra i primi – ricercano, in ogni loro lavoro, quell’occhio non partecipe: umanissimo, empatico, ma incapace di comprendere fino in fondo la natura dell’uomo, i suoi errori, le sue passioni.
Conrad e Nabokov, dunque, posti agli antipodi per quanto riguarda l’aspetto estetico delle loro opere, e senza alcuna intersezione per quanto riguarda gli argomenti scelti, si trovano intimamente connessi per quanto riguarda lo sguardo, la qualità della visione, la distanza del mondo che raccontano: e tutto questo, con buona pace dell’intemperante Nabokov, e del serioso Conrad.




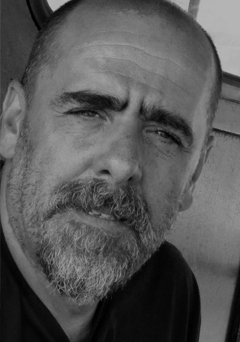
4 Comments
Ti senti ancora al sicuro dopo aver intaccato il mito di David Foster Wallace?
Hanno tolto la scorta a Saviano e l’hanno data a me!
Dopo affermazioni simili, rischi più tu di Saviano. 🙂
Prima di toccare Paolo devono passare sul gigantesco cadaverozzo dello Zio… (non nel senso del padre dei suoi cugini, ma nel senso di muà…) 🙂